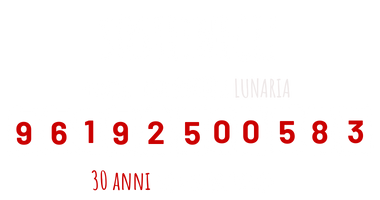Parlare di sostenibilità significa essere consapevoli che produrre nel rispetto della natura è condizione certo necessaria, ma non sufficiente: occorre anche contrastare il dogma della crescita infinita del PIL e affrontare i problemi della crisi del sistema economico capitalistico.

di Mauro Gallegati
Il concetto di sostenibilità è oggi di gran moda. Il Rapporto Brundtland del 1987 definisce come “sviluppo sostenibile” quello che soddisfa i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità di quelli delle generazioni future. Ma questo non è possibile per via dei principi della fisica e della termodinamica: non c’è modo per lasciare in eredità alle prossime generazioni la Terra così come noi l’abbiamo trovata poiché è impossibile realizzare un processo che sia efficiente al 100%, ovvero che non inquini.
Quando parliamo di sostenibilità non dobbiamo illuderci che questa possa davvero permetterci di crescere per sempre poiché, per quanto possiamo essere tecnologicamente avanzati, non saremo mai perfetti e inquineremo il Pianeta. Se la termodinamica ci dice che non saremo mai in grado di non produrre scorie, che non potranno mai più rientrare nel ciclo produttivo, i processi di riciclo o recupero, in quanto processi termodinamici produrranno scorie non più utilizzabili. Per quanto ci impegneremo per riciclare, ogni nostro sforzo non sarà mai in grado di violare la termodinamica. Dovremmo certo aspirare a processi produttivi meno inquinanti, ma senza illuderci che l’economia circolare – una crescita economica senza distruzione o spreco – sia possibile o che – come sostiene l’Unione Europea – questa “promuoverà una crescita economica sostenibile”.
In economia, come in tutti i processi irreversibili, le risorse non possono essere continuamente riutilizzate, il che significa che ci sono attività estrattive o produzione di rifiuti non riciclabili. Un uso più responsabile delle risorse è ovviamente un’ottima idea. Ma per raggiungere questo obiettivo, il riciclaggio e il riutilizzo non sono sufficienti.
Lo sviluppo sostenibile non è un ossimoro se si rispettano quattro condizioni: l’utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere inferiore al loro reintegro; lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo; il processo di produzione non deve essere soggetto alle leggi della fisica; e l’inquinamento dell’ambiente non deve superare la capacità di carico dell’ambiente stesso. Le prime due sono condizioni economiche – da leggere tra l’altro in rapporto a una popolazione che è quasi triplicata negli ultimi 60 anni – mentre le altre ci ricordano che siamo parte della natura e che, poiché i tempi di reazione di questa sono assai diversi da quelli dell’economia, rischiamo di abbuffarci oggi e morire di fame domani.
L’uroboro, un serpente mitologico che si nutre cibandosi della propria coda che continuamente ricresce, è una perfetta rappresentazione dell’economia circolare. Peccato sia – come la sostenibilità – solo un mito. Produrre rispettando l’ambiente è dunque necessario, sebbene non sufficiente. Se è vero che “l’età della pietra non ebbe fine perché finirono le pietre”, quella dei combustibili fossili non avrà termine con la loro disponibilità, ma perché il loro uso sta distruggendo la vita umana. Raggiungere la consapevolezza che solo producendo rispettando la natura ci sarà un futuro, non è però sufficiente. Le condizioni sopra ricordate ci ammoniscono a contrastare il dogma della crescita infinita del PIL e ad affrontare i problemi della crisi del sistema – distribuzione iniqua, povertà e precarietà in aumento. Si può così individuare un disegno strategico in due parti: produrre in modo compatibile con l’ambiente e con l’umanità, cioè col benessere e non col PIL.
Si può cambiare l’alimentazione dell’automobile – evitando l’inquinamento – ma se si vogliono evitare gli incidenti stradali dobbiamo modificare opportunamente la macchina. Il capitalismo ha invece dimostrato che il mercato non si regola da solo, producendo ad esempio troppo inquinamento e poca ricerca. Dobbiamo ridurre la produzione di inquinamento, ma anche cambiare un sistema che non si autoregola passando dal mito della crescita infinita del PIL all’abbastanza (la Felicità Interna Lorda del Buthan è un primo riferimento, dove sono garantiti i diritti di base, un sistema educativo e uno sanitario gratuito). Poter credere di attribuire un prezzo a tutto – come fa il PIL – è estremamente limitativo, perché non si possono valutare in termini economici salute e benessere. Se è difficile quantificare i danni diretti operati dall’uomo nel corso delle sue attività produttive, appare ancora più difficile calcolare il costo delle ripercussioni indirette, come quelle causate dai cambiamenti climatici.
Per esempio, oggi possiamo restaurare gli ecosistemi degradati, utilizzare l’ecologia industriale, sviluppare sistemi innovativi per ridurre l’anidride carbonica, gestire in modo virtuoso la natura rispettando i suoi processi. Ma tutto questo finirà con lo scontrarsi con un sistema guidato dalla massimizzazione del PIL – e che cerca una impossibile giustificazione nella “teoria” neoliberista che non si preoccupa della sua distribuzione e degli effetti della produzione sull’ambiente. Mi piace concludere con le parole di Fuà: “ogni Paese dovrebbe perseguire la sua propria via, quella che la sua peculiare cultura gli indica, rifiutando il precetto di un unico percorso da seguire”, quello di massimizzare la crescita, soprattutto ora che occupazione e PIL sono slegati.